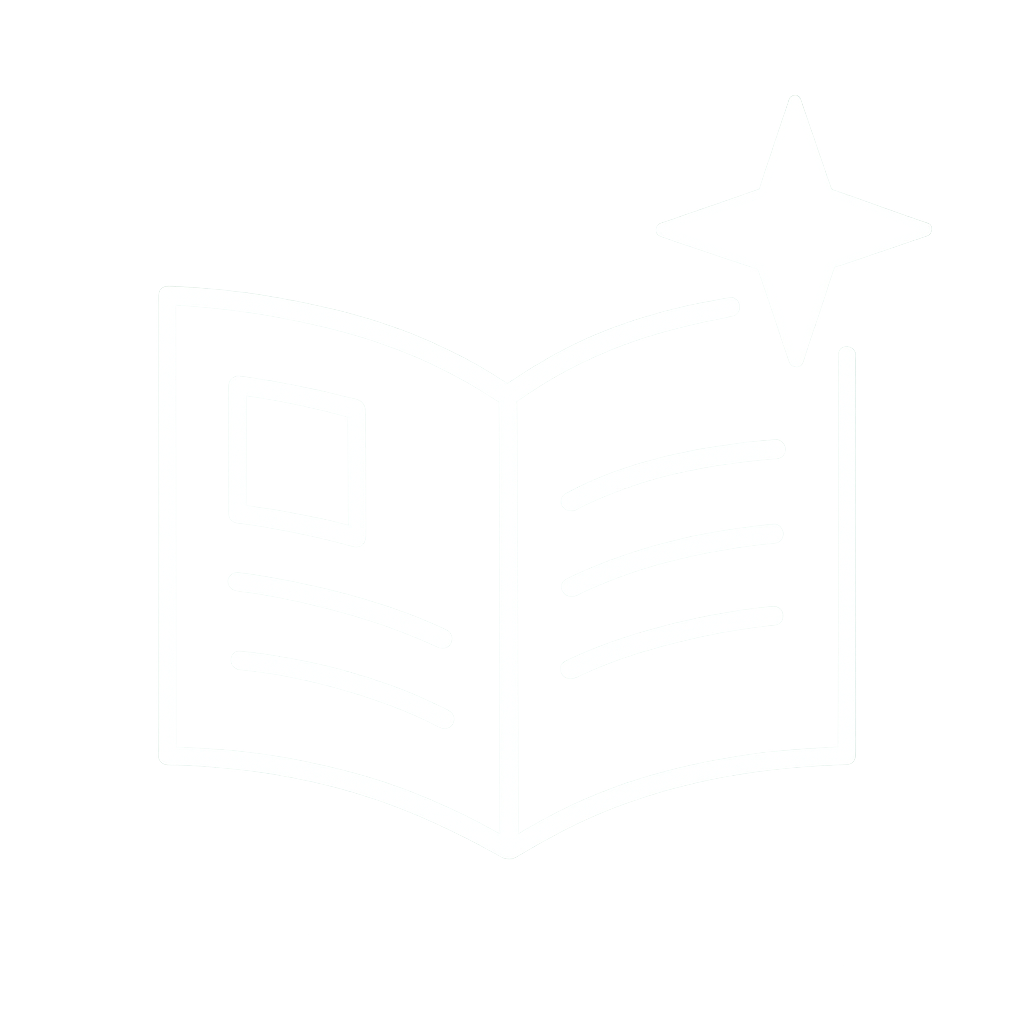Un crimine chiamato guerra
Pubblichiamo online la postfazione di Sandro Moiso al Quaderno di Into the Black Box #7 Una congiuntura di guerra. Il volume è scaricabile gratuitamente al link disponibile sul nostro sito e sui nostri canali social.
* * *
_Si fa il male per essere grandi, per essere dèi
_(Cesare Pavese, _Dialoghi con Leucò_)
_Nulla sarebbe più nefasto se il proletariato preservasse dall’attuale guerra mondiale una pur minima illusione e speranza sulla possibilità di una continuazione idilliaca e pacifica del capitalismo
_(Rosa Luxemburg, _Juniusbrochüre_)
_Warzone,warzone / We’re living in a warzone / It’s a warzone_
(Yoko Ono, _Warzone_ , 2018)
A un primo e disattento sguardo si potrebbe osservare che la guerra, come attività distruttiva e di conquista, costituisca una caratteristica ineludibile delle società umane. E, effettivamente, un certo grado di violenza ha sempre caratterizzati rapporti all’interno della specie e della stessa con l’ambiente circostante fin dalle sue origini.
Pensando anche soltanto ai graffiti lasciati dai nostri antenati sulle pareti delle grotte di Lascaux in Francia o, più a nord, oltre il circolo polare artico, ad Alta in Norvegia, oppure ancora ai più recenti graffiti in Val Camonica, è evidente che l’uso della forza organizzata socialmente almeno per la caccia di grossi animali e di branchi interi ha costituito un elemento obbligato per lo sviluppo delle primitive società di cacciatori-raccoglitori.
Si ricorda questo aspetto soltanto per sottolineare come l’uso della violenza o della forza organizzata non costituisca, come oggi troppo spesso si tende ad enfatizzare, una deviazione da un’etica che si vorrebbe data una volta per sempre e che, anzi, dovrebbe costituire una delle principali caratteristiche dell’essere umani.
Gli stessi scavi archeologici e le ricerche paleontologiche, oltretutto, continuano a riportare alla luce resti umani, sia maschili che femminili, sui quali i segni della violenza sono ancora, a migliaia di anni di distanza, ben visibili. Confermando spesso che il ruolo “attivo” nell’uso della violenza non sia sempre e solo stato caratteristico del carattere maschile.
Le idealizzazioni e le semplicistiche formulazioni di possibili scenari alternativi per la storia passata non sono certo utili alla comprensione della stessa e non fanno altro che proiettare immagini utopiche, prodotte nel tempo recente, sul passato.
Anche le guerre portate a termine dalle civiltà successive, che spesso hanno costituito come nel caso dell’ _Iliade_ omerica il fondamento dello sviluppo dell’immaginario “eroico” dell’Occidente, non possono essere messe in un unico calderone cui dare il nome di «guerra» e come tale usarlo per definire il fenomeno una volta per tutte. Ieri, oggi, domani: senza alcun riferimento alle motivazioni materiali e ai modi di produzione che, di volta in volta, l’hanno determinata, la determinano e, purtroppo, la potrebbero determinare ancora nell’immediato futuro.
Certo, fin dal poema omerico, passando per il _Mahābhārata_ per poi giungere a ricostruzioni di carattere storico come _La guerra del Peloponneso_ di Tucidide o _La guerra gallica_ di Giulio Cesare, le memorie e le pagine antiche sono cariche di episodi di violenza belluina e di distruzioni crudelissime di vite umane.
Certamente, proprio a partire dal poema indiano appena citato, su questa narrazione violenta del passato si è anche basato il mito di una razza, quella degli Arii [1], che della propria forza e determinazione avrebbe fatto la propria caratteristica, giustificandone il diritto a dominare sui popoli sottomessi. Proposizione che si rifletterà nelle caste guerriere che domineranno per diversi secoli l’Europa, tra la caduta dell’Impero romano e i primi secoli dopo il Mille a seguito delle successive invasione di popoli di stirpe germanica.
L’aristocrazia feudale medievale, infatti, proprio sul “gioco crudele “ della guerra avrebbe fondato il proprio potere e il proprio diritto a governare e a nominare i re. Un gioco riservato principalmente a uomini cresciuti e addestrati nel culto della guerra, all’interno della quale il ruolo delle fanterie, costituite principalmente da contadini e servi trasformati alla bisogna in soldati, sarebbe per diversi secoli rimasto secondario. Lasciando così alla cavalleria il ruolo di protagonista, anche in termini di perdite e violenza esercitata e subita.
Una società cavalleresca che si sarebbe anche espressa in nuovi poemi, dal _Ciclo Arturiano_ alla _Chanson de Roland_ , sviluppatisi essenzialmente in terra di Francia. Poemi che esaltavano la figura del nobile cavaliere, rimuovendo del tutto il carico di violenza che questo poteva esercitare sugli strati inferiori della popolazione, sottoposta, spesso, a soprusi, imposizioni e umiliazioni, e che a loro volta furono alla base delle rivolte contadine destinate a mettere in crisi lo stesso ordinamento sociale feudale[2].
Sarà soltanto con l’avvento delle milizie mercenarie e, soprattutto, con quello dell’arma da fuoco, che tali figure cavalleresche avrebbero dovuto lasciare sempre più il campo alle fanterie, ben inquadrate e armate di picche e archibugi, che avrebbero finito col portare lo scompiglio e la sconfitta tra le schiere dei vecchi professionisti della guerra.
Soprattutto dopo la battaglia di Pavia (24 febbraio 1525), in cui l’esercito francese guidato personalmente dal re Francesco I sarebbe stato duramente sconfitto dall’armata imperiale di Carlo V, formata da 12000 lanzichenecchi tedeschi e 5000 soldati dei tercio[3] spagnoli, che fece prigioniero lo stesso re di Francia. L’episodio avrebbe in seguito svolto un ruolo non secondario nel cambiamento dell’immaginario collettivo[4], artistico e popolare.
Un cambiamento di prospettiva che non solo e già prima aveva permesso ad un poeta di corte come Ludovico Ariosto di irridere la figura del cavaliere con un poema (prima edizione 1516) in cui il paladino più noto della cristianità, Orlando o Rolando, non solo perdeva il senno, ma si trasformava in un’autentica belva destinata, una volta persi i paramenti della nobiltà (corazza, armi, elmo e scudo), a distruggere più che gli avversari militari, la vita e gli averi di pastori, agricoltori e abitanti dei borghi[5]. Ma che, successivamente, avrebbe rivelato tutta la fragilità, anche militare, di un sistema che si riteneva innato: quello della tripartizione dei ruoli tra chierici, guerrieri e contadini. Scoperta e allo stesso tempo anche rifiuto che avrebbe da lì a poco portato alla guerra dei contadini tedeschi (ma non solo) che coinvolse al suo apice, nella primavera-estate del 1525, un numero stimato intorno ai 300 000 insorti.
Il periodo tra il XVI e il XVII secolo si rivela così come un autentico _turning point_ per la storia non solo economica, sociale e coloniale dell’Europa, e dei continenti conquistati con la forza, ma anche per quella militare. Nascono infatti i quel periodo gli eserciti direttamente finanziati dai governi e dagli stati sovrani, si diffonde a macchia d’olio l’uso delle armi da fuoco e delle artiglierie (navali e di terra), giungendo a determinare la fine di quei castelli le cui alte mura e torri avevano rappresentato, non solo simbolicamente, il potere feudale.
Cambia dunque il ruolo della nobiltà, che nel frattempo si è imborghesita, e nascono gli eserciti moderni, in cui il potere della finanza per armarli e sostenerli diventa importante quanto quello dell’addestramento all’uso delle armi e della logistica.
La guerra civile europea rappresentata dalla Guerra dei Trent’anni (1618-1648) avrebbe costituito un passaggio decisivo verso le guerre moderne del capitale che dopo aver imposto quella senza quartiere ai popoli altri, con cui la “civiltà cristiana” era entrata in contatto, l’avrebbe importata sul suolo europeo in occasione di quelle che furono definite anche come «guerre di religione», il cui imperativo sarebbe stato quello di arrendersi e sottomettersi oppure perire.
Complessivamente si stima che la Guerra dei Trent’anni sia costata all’Europa tra i diciotto e i venti milioni di morti, considerato anche che ai disastri provocati dal conflitto stesso (battaglie, saccheggi, distruzioni) andarono ad aggiungersi carestie prolungate ed epidemie ricorrenti di peste bubbonica e polmonare. Causate non per ultime dalle compagnie mercenarie che per un periodo sembrarono poter addirittura prendere il sopravvento decisionale e militare sugli stessi stati e imperi[6].
Se, da un lato, un tale disastro umano ed economico sarebbe stato destinato a infiammare l’immaginario millenaristico della guerra civile o Prima Rivoluzione inglese (1642 – 1651), che nel 1649, fu per la prima volta testimone dell’esecuzione “sacrilega” di un re da parte del popolo e dei suoi rappresentanti, dall’altro avrebbe anche convinto i governanti della difficoltà insostenibile di una guerra di tal fatta, sia dal punto di vista dei costi che della riduzione del numero dei sudditi civili. Aprendo così la strada a quelle guerre “barocche” in cui le manovre ben ordinate e lo schieramento sul campo avrebbero spesso, anche se non sempre, determinato l’esito delle battaglie.
Sarebbero poi state la Guerra di indipendenza americana, la guerra dei Sette anni e la Rivoluzione francese, soprattutto con l’avvento di Napoleone e del suo pensiero militare, a riportare il treno della guerra sui binari della ormai prossima modernità. Sia in chiave di distruttività che di sviluppo delle tecnologie applicate alla distruzione degli esseri umani. Essendo le guerre, dalla fine del XVIII secolo in poi, il frutto del tanto vantato progresso introdotto dalla Rivoluzione industriale.
Motivo per cui la guerra civile americana (1861-1865), la guerra franco-prussiana e le guerre coloniali, soprattutto in Africa, degli imperi europei, avrebbero poi posto definitivamente le basi per le guerre del XX secolo con l’uso di fucili a ripetizione, mitragliatrici e trincee[7].
Era così aperta la strada al primo grande macello imperialista, meglio noto come Prima guerra mondiale, che avrebbe poi informato di sè tutto il secolo successivo, e ancora l’attuale, non solo dal punto di vista militare, ma anche politico, ideologico, economico, produttivo, sociale e ambientale.
Ma, occorre qui dirlo, tale distruttività sistemica che avrebbe visto crescere in maniera esponenziale sia le distruzione che il numero di vittime militari[8] e civili, soprattutto queste ultime a partire dalla Seconda guerra mondiale[9] soprattutto a causa dei bombardamenti a tappeto su obiettivi civili teorizzati fin dal 1921 dall’italiano Giulio Dohuet[10], affondava e tutt’ora affonda le sue radici in un modo di produzione che della guerra ha fatto, a ogni livello, la sua norma esistenziale. Più, e forse al contrario, di ogni altra società precedente. In cui la guerra poteva essere sì crudele e spietata, ma quasi sempre rappresentava un momento transitorio, di passaggio si potrebbe dire, necessario ma non di primario interesse per la stessa. Compresa quella cavalleresca.
L’attuale attenzione per la guerra o le guerre in corso che l ’odierna crisi militare, politica ed economica internazionale, che vede coinvolti attori grandi e piccoli della scena geopolitica mondiale, risvegliatasi nei media, nei discorsi governativi e in un’opinione pubblica in gran parte tutt’altro che favorevole a farsi macellare in nome dei più alti ideali di libertà e “democrazia” suggeriti dai primi due, ci deve però spingere ad individuare i caratteri di una tendenza alla guerra che caratterizza i rapporti di produzione, scambio e ridistribuzione della ricchezza della società venutasi a costituire non solo nel corso del XX secolo, ma fin dai tempi dell’accumulazione originaria e delle successive e diacroniche rivoluzioni industriali.
Una società o un’economia, quella che per comodità espressiva si può definire _tout court_ come capitalistica, che fin dalle sue origini ha fatto della prevaricazione e della sottomissione della specie e della natura agli interessi di pochi la sua normale condizione di esistenza. Una società in cui la concorrenza tra gli individui, le imprese, le nazioni e gli imperi economici e politici costituisce la pratica quotidiana, data per scontata, inevitabile e irrimediabilmente destinata a dare vita a conflitti di ordine giuridico, militare, politico e di classe.
Conflitti e contraddizioni, destinati a sorgere e ad ingrandirsi in maniera esponenziale, che non costituiscono la conseguenza di anomalie del sistema oppure i suoi frutti marci o una momentanea necessità, ma, al contrario, il pieno realizzarsi di un avvicendamento politico, economico e militare che non potrà aver fine se non con un radicale rovesciamento della sua essenza e dei suoi paradigmi.
Come affermava ancora Rosa Luxemburg, già citata in epigrafe, «il suo ulteriore dominio non è compatibile con il progresso dell’umanità»[11] poiché per la prima volta nella storia, sfruttamento e disoccupazione, alienazione e crisi, guerra e distruzione non sono i prodotti accidentali e gli effetti collaterali di una dato modo di produzione e riproduzione della vita e del suo sostentamento, ma, piuttosto, la sua inevitabile e necessaria conseguenza, la sua «condizione di vita».
In una società in cui, arricchendo la definizione data da Thomas Hobbes con l’intuizione di John Stuart Mill, _Homo oeconomicus – homini lupus_ , l’uomo egoisticamente rivolto alla realizzazione del proprio interesse individuale è lupo tra gli altri uomini, la polemologia, lo studio della guerra e delle sua cause psicologiche e sociali, pare essere, insieme alla critica del modello sociale basato sull’estrazione del plusvalore, lo strumento più adatto per comprendere i rapporti tra uomini, imprese, classi e nazioni.
Tanto da spingere in direzione di un ribaltamento della celebre frase di Karl von Clausewitz, “la guerra non è che la continuazione della politica con altri mezzi”, tratta dalla sua opera più celebre, in ”la politica non è che la continuazione della guerra con altri mezzi” come intuì già più di quarant’anni fa Michel Foucault.
La guerra è la norma di esistenza di un modo di produzione basato sull’appropriazione circoscritta e privata della ricchezza socialmente prodotta e la politica che accompagna la sua azione sociale, sia nelle fasi in cui le armi tacciono che in quelle in cui le stesse sgranano i loro tristi rosari di morte, è sempre una politica di guerra. Anche perché, a ben vedere, è difficile differenziare nettamente le due attività, quella politica e quella militare, considerando i conflitti armati che sembrano accompagnare, vicini o lontani che siano, ogni fase del percorso della società in cui siamo immersi.
Soprattutto in una fase storica in cui la rimozione del discorso della guerra dall’orizzonte politico è stata a lungo accompagnata da una militarizzazione costante della società civile. Non soltanto perché sempre più spesso le operazioni militari sono state definite come “missioni di pace” oppure “di polizia internazionale”, ma soprattutto perché le politiche securitarie, portate avanti da anni contro i migranti, il terrorismo vero o presunto e i conflitti sociali territoriali (come quelli del Valsusa e della Zad, solo per citarne alcuni) hanno abituato i cittadini degli stati ancora “non belligeranti” ad una presenza costante dei militari sul territori metropolitani e ad un uso sconsiderato delle armi da guerra (gas CS, granate accecanti e stordenti, proiettili di gomma ad alta velocità, autoblindo nelle città e durante le manifestazioni, la definizione delle grandi opere inutili come “opere di importanza strategica” ) che di fatto hanno finito col trasformano ogni dettaglio del cosiddetto ordine pubblico in un’azione militare vera e propria.
Senza considerare poi il fatto che gli stessi videogame di carattere bellico abituano, fin dalla più tenera età, i giocatori ad utilizzare di fatto quelli che nella guerra condotta “a distanza” saranno poi i droni, i visori notturni e allo stesso tempo allo sterminio di un nemico disumanizzato per procedere nel gioco e passare a livelli superiori di complessità e di violenza. Come le trasformazioni tecnologiche avvenute direttamente sul campo in Ucraina, ma anche in Medio Oriente e a Gaza hanno spietatamente confermato e ancora confermano.
Un po’ come per la morte, l’Occidente sembrava poter allontanare da sé il _memento mori_ per fingere che morte, anch’essa dipinta sempre più spesso come un fatto casuale e inaspettato, e guerra siano in fin dei conti frutto di errori e di problemi ancora non risolti dallo stesso ordine sociale che ne causa il rinvigorimento e la massiccia diffusione. Una sfortunata disgrazia insomma, e nulla più.
Con la conseguenza che a partire dal 2022, non importa qui delineare le responsabilità di quel conflitto allora apertosi e ancora ben lontano da una possibile conclusione, davanti alla politica occidentale si è aperto un autentico baratro, che si è cercato di riempire con vacue promesse di vittoria sulla barbarie asiatica o sulle autocrazie, e con lo sviluppo di economie di guerra che per ora hanno soltanto ridotto all’osso la spesa sociale, soprattutto in quell’Europa occidentale che aveva fatto del welfare lo _status symbol_ di una integrazione tra le classe e le etnie mai realmente realizzata e, anzi, in fase di decurtazione ormai da anni.
Cosa cui i recenti, pesanti dazi di Donald Trump, insieme alla richiesta di spesa per armamenti americani attraverso la NATO, che dovrebbe accollarsi il cento per cento della spesa per il rifornimento dell’esercito ucraino, hanno tolto la residua speranza di ripresa attraverso un rilancio dell’industria bellica che, per quanto barbara, costituiva l’unica arma politica, economica e mediatica per i governi attualmente in carica in Europa. Soprattutto dopo le letali sanzioni, per l’economia europea, adottate «per costringere Putin alla resa». Arma che si è sempre accompagnata a quella di dichiarare «crimine di guerra» quasi ogni azione portata a termine dagli avversari, dimenticando o, meglio, nascondendo il fatto che ogni atto di guerra e della sua economia politica costituisce già di per sé un crimine: contro la specie, l’ambiente e la vita sul pianeta.
Quest’ultimo punto va sottolineato non in nome di un generico e inutile pacifismo, di cui chi scrive queste righe non è affatto sostenitore, ma per sottolineare come le distruzioni, le violenze , gli stupri, le mutilazioni degli adulti e dei bambini, la loro morte, la fame, il freddo, la mancanza di acqua e l’inquinamento di ogni possibile risorsa d’acqua e agroalimentare sono tutte il naturale corollario delle guerre del capitale. Non importa da che parte siano state dichiarate, perse o vinte.
Considerato, inoltre, che proprio questo modo di produzione ha portato la guerra sull’orlo dell’Apocalisse per mezzo di quelle bombe atomiche che quarant’anni fa erano state testate su Hiroshima e Nagasaki, e che oggi, in un contesto in cui molti governi hanno già scelto la Bomba come arma di pronto impiego, come ad esempio fa pensare la Dichiarazione di Northwood del luglio di quest’anno, per la fornitura di un ombrello nucleare all’Europa da parte di Francia e Regno Unito, per cui la l’atomica torna
_“ad essere quel che fu ottant’anni fa, a Hiroshima e a Nagasaki: estremo rimedio per finire il nemico. Ma in un contesto drasticamente diverso. La guerra dei dodici giorni fra Israele e Iran con la partecipazione straordinaria degli Stati Uniti non sarà ricordata per i suoi modesti esiti tattici ma per lo sconvolgimento che ha innestato su scala globale. Perché ha sancito la fine della deterrenza nucleare basata sulla mutua distruzione assicurata. Gli arsenali nucleari effettivi e latenti non assicurano più la vita di chi li possiede, per esempio Israele, o potrebbe presto dotarsene, come l’Iran. […] Il regime di non proliferazione formalizzato dal trattato voluto nel 1968 dai detentori della Bomba per impedire che altri se ne dotassero è saltato da tempo. Siamo a quota nove potenze nucleari, con l’Iran sulla soglia e otto variamente latenti […] I furbetti della latenza sono ormai smascherati. Giappone su tutti, poi Germania, Corea del Sud, Canada, Paesi bassi, Brasile, Argentina, Taiwan. Presto anche Turchia e Arabia Saudita. persino in Italia potrebbero riaffiorare sepolte velleità nucleari, espresse nel programma segreto franco-germanico-italiano del 1957, bloccato dagli americani (poi da De Gaulle)”[12]._
Va poi ricordato che ogni guerra e lo stesso sistema di guerra su cui si basano i rapporti socio-economici di stampo capitalistico rappresenta, si scusi la ripetizione, un percorso di guerra commerciale, economica, finanziaria, ambientale, politica e militare rivolta non soltanto contro i potenziali avversari esterni ma, e forse soprattutto, verso l’interno delle proprie aree nazionali e metropolitane e le comunità che le abitano.
Base di una possibile guerra civile, di cui da tempo si avvertono prodromi negli Stati Uniti e nella loro crisi che l’attuale presidente cerca di attutire con _escamotage_ economici, politici e diplomatici rivolti a danneggiare soprattutto gli alleati di un tempo, ma oggi troppo pericolosi dal punto di vista della concorrenza e, soprattutto, del costo per la loro protezione.
Una guerra civile strisciante che è già operante anche qui in Europa e in Italia dove, dalla ZAD alla Valsusa e ogni altro luogo in cui si resiste al modo di produzione dominante e alla sua distruzione dell’ambiente, dei territori e dei rapporti interni alla specie umana per sostituirli, come già detto, con quelli basati sulla competizione e l’odio reciproco, l’azione dello Stato e del suo braccio armato repressivo (polizia, magistratura, forze armate nazionali e mercenarie) assume fisionomie sempre più rigide e aggressive.
Una guerra civile che i media stanno preparando e sostenendo, come i conflitti militari esterni, parlando di pacificazione, modernizzazione e democratizzazione.
La resistenza all’estrattivismo e allo sfruttamento dei territori e delle risorse economiche disponibili attraverso l’impianto di grandi opere inutili e dannose va trattata come un tempo i popoli che si opponevano alla colonizzazione europea e proprio come allora chi si oppone al “progresso” deve essere distrutto, umiliato e cancellato dalla faccia della Terra.
Una guerra civile che, sulle tracce di Lenin, secondo le riflessioni del recentemente scomparso Emilio Quadrelli (1956- 2024)[13], potrebbe, pur all’interno di una guerra di più vasta portata, contenere in sé i germi di un radicale cambiamento dell’esistente. Anche se, in chiusura, quest’ultima riflessione porta chi scrive a ricordare che qualsiasi guerra può costituire un crimine, poiché fare la guerra significa sporcarsi le mani di sangue. Fatto che in sé non può essere né dimenticato né rimosso o, ancor meno, esaltato e rivendicato con la scusa della vendetta o della “giustizia proletaria”. Proprio per impedire che ancora una volta un’eventuale rivoluzione politica finisca col rinnovare solamente i fasti di ciò che si sarebbe voluto abbattere.
* * *
[1] Il _Mahābhārata_ è un poema epico dai contenuti mitici e religiosi che narra il lontano passato degli Arii, ovvero di un popolo indoeuropeo invasore dell’India. Intriso di epica guerriera propria degli _kṣatriya_ (la casta guerriera), la vicenda si svolge nella regione del Doab, ovvero nell’area compresa tra il fiume Gange e il fiume Yamunā che corrisponde a uno dei primi stanziamenti del popolo degli Arii.
[2]Si vedano in proposito i recentissimi: AA.VV., _Taboriti. Apocalisse anarco-comunista in Boemia. Analisi e documenti di una rivoluzione tardo medievale_ , edizioni Tabor, 2025 e AA.VV., _Tumulti rusticani. Rivolte e resistenze contadine tra il Medioevo e la Modernità_ , edizioni Tabor, 2025.
[3]Il _tercio_ era un’unità militare dell’esercito spagnolo, utilizzato dai monarchi cattolici nel periodo degli Asburgo. Questa formazione di fanteria, composta all’incirca da trecento soldati tra picchieri e moschettieri, si rivelò fondamentale per le guerre tra il XVI e il XVII secolo. Il termine derivava dall’italiano “terzo”, indicando una divisione in tre parti e, di fatto, un’unità d’èlite.
[4]Si pensi soltanto al poema ariostesco _Orlando furioso_ che nel 1532, con l’edizione definitiva cantò «la brutta invenzione dell’arma da fuoco» (canto XI, vv. 23-28).
[5]Canti XXIII e XXIV.
[6]Si veda in propossito: G. Mann, _Wallenstein_ , Sansoni editore, Firenze 1981.
[7] A solo titolo di esempio occorre qui sottolineare che nella guerra civile americana, o Guerra di Secessione, si stima che tra il 1861 e il 1865 vi furono almeno 620 000 morti, anche se studi più recenti sostengono che 750 000 soldati siano caduti, con un numero imprecisato di civili. Secondo tali stime la guerra causò la morte del 10% di tutti gli uomini degli Stati del Nord tra i venti e i quarantacinque anni e il 30% di tutti gli uomini del Sud tra i diciotto e i quarant’anni.
[8] La stima del numero totale di vittime della prima guerra mondiale non è mai stata determinata con certezza e varia molto: le cifre più accreditate parlano di un totale, tra militari e civili, compreso tra 15 milioni e più di 17 milioni di morti, con le stime più alte che arrivano fino a 65 milioni di morti includendo nell’insieme anche le vittime mondiali della influenza spagnola del 1918-1919.
[9]I dati odierni riguardanti le vittime del secondo conflitto mondiale si aggirano introrno ai 70 milioni di cui 45 milioni civili. Probabilmente, però, si tratta di un calcolo ancora al ribasso.
[10]Che, prima delle atomiche di Hiroshim e Nagasaki, avrebbero raggiunto il loro apice con quelli di Dresda (13 e 15 febbraio 1945) e di Tokyo (9 e 10 marzo 1945).
[11]R. Luxemburg, _« Juniusbrochüre»_ _.La critica dell’economia politica_ , in Id._Scritti scelti_ , a cura di L. Amodio, Einaudi, Torino 1976, p. 513.
[12] _Quando non ci sei non capisco dove mi trovo_ , editoriale di «Limes», n° 6/2025, pp. 7-8.
[13]E. Quadrelli, _Sulla guerra. Crisi Conflitto Insurrezione_ , con quattro contributi di G. Bausano, Red Star Press, Roma 2017.